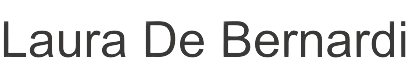Testo critico di Flaminio Gualdoni
Insegnamento di Storia dell’arte antica presso l’Accademia di Belle Arti di Brera (Milano)
Ho seguito il percorso di formazione di Laura De Bernardi (1970) sin dalla metà degli anni Novanta, quando l’ho avuta come allieva all’Accademia di Brera, Milano, individuandola subito come un caso di autentico spessore. Era sin da allora notevole che il suo approccio al patrimonio problematico e d’esperienza dell’arte povera che ha caratterizzato la gran parte del dibattito artistico dalla fine degli anni Sessanta in poi – ha studiato a lungo anche con Luciano Fabro – non riguardasse in senso stretto i materiali e il loro uso, e neppure il grado di formalizzazione della pratica, quanto la questione – che era radicale, e decisiva – del fare, dell’agire, implicando nell’atto lo scrutinio profondo del rapporto ancestrale con la propria corporeità, con la mano come strumento di intelligenza e conoscenza, come techne originaria, e dell’evolvere alla consapevolezza del “sentirsi vivere” e dell’opera in fieri.
Il suo approccio alla manualità si è svolto a partire dalla fondazione paleoantropologica dell’argomento, con implicazioni sociologiche alte, enunciata da André Leroi-Gourhan nel fondamentale Le geste et la parole, Parigi 1964 e 1965. De Bernardi, ponendosi in posizione di critica riflessiva rispetto alla tendenza sociale moderna a svalutare l’azione tecnica diretta dei gruppi umani in favore dell’adesione ai portati delle novità tecnologiche, in uno scenario che già prefigurava la rivoluzione digitale, ha inteso l’ambito artistico come quello in cui maggiormente si poteva verificare una fondazione di valore e di consapevolezze altra da parte dell’individuo. Ha scelto di non elaborare una semplice enunciazione teorica del proprio riflettere sul tatto, il senso in cui si verifica e si distilla un agire estetico che può rivelarsi come valore in se stesso, ma di verificarlo in the matter, non solo come epicentro dell’azione tecnica corporea ma anche come misura intima della consapevolezza fisica e intellettuale dell’individuo.
Proprio alcune esperienze dei decenni in cui all’arte povera e, più, al concettualismo, si affiancavano operazioni di pratica deliberatamente “regressiva” del fare in vista di una distillazione del rapporto ancestrale della mano con le cose – Eva Hesse, Joseph Beuys, Claudio Costa – sono state all’origine della ricerca tenace, continua, senza deviazioni solamente estetiche ma sempre fondata su uno stato di interna necessità, di De Bernardi (la quale intende il proprio lavoro come ricerca svincolata dagli statuti cogenti della professione dell’arte), e l’hanno portata a risimbolizzare aspetti del fare, come l’attenzione a lacerti della realtà naturale legati all’atavico raccogliere/manipolare, a procedimenti come il cucito che tramano non tanto forme costituite quanto la sedimentazione di un tempo, di un ritmo, di una “respirazione” degli atti: per dire con Pierre Restany, una “reinvenzione poetica della realtà”.
Nel contesto prefigurato dall’occasione attuale, un intervento di De Bernardi intende porsi come un incidente concettuale di livello radicale, il cui ruolo potrebbe essere di suggestione di quale sostanza e quale ragione di tattilità siano in gioco, non evitabili non trascurabili, anche nell’ambito dell’intelligenza artificiale.

Flaminio Gualdoni
Insegnamento di Storia dell’arte antica